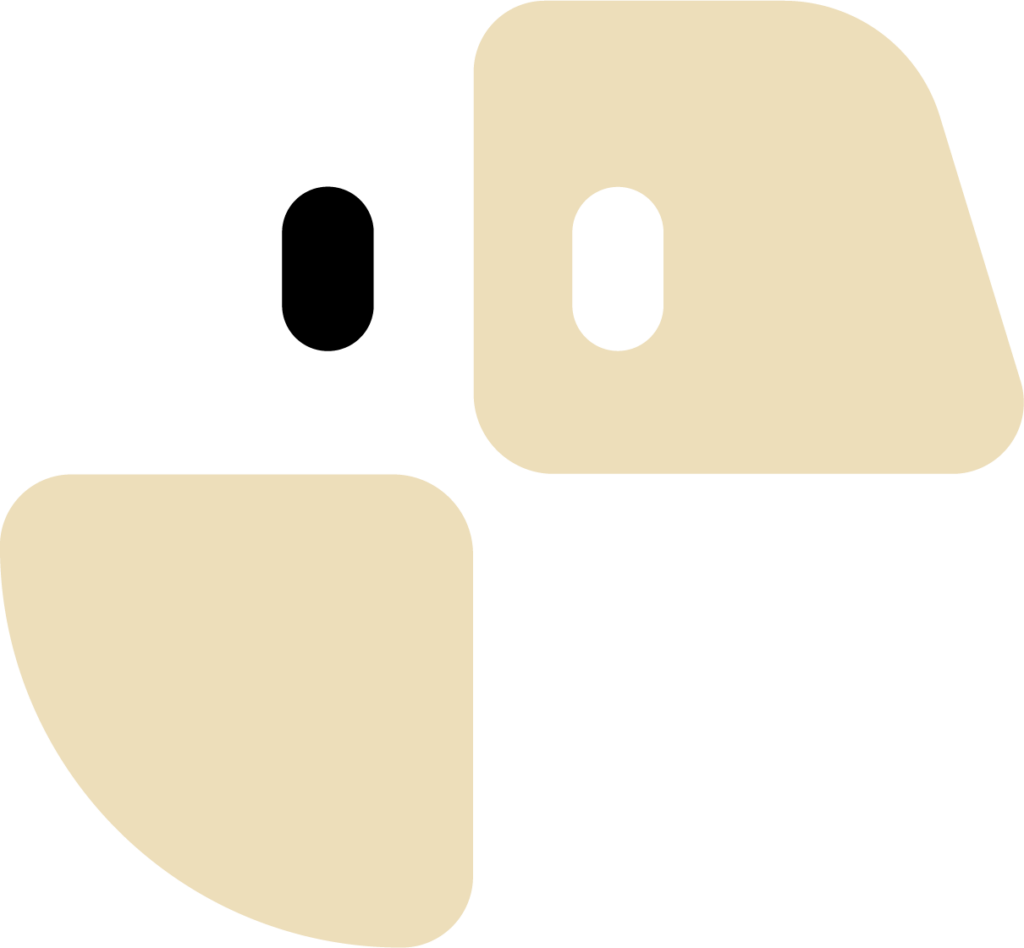1, 2, 3, 4
Contare è una delle abilità astrattive che forse più di tutte riteniamo scontate. La capacità di distinguere piccole quantità in modo immediato e preciso, definita “subitizing”, si sviluppa nel bambino fin dai primi mesi di vita: attorno ai tre anni siamo già in grado, di fronte ad un piccolo gruppo di oggetti, di distinguere all’istante l’unità dalla coppia e dalla terna e, come noi, anche altri animali.
Quando contiamo non facciamo altro che raggruppare gli elementi di un insieme esteso in sottoinsiemi più piccoli, dei quali siamo in grado di cogliere in maniera immediata la quantità: un range di subitizing non troppo esteso in effetti, che non si spinge al di là del numero 4.
Per una cultura come la nostra, addestrata da migliaia di anni alla pratica del “contare”, questa potente capacità astrattiva di dividere insiemi più ampi in quantità immediatamente percepibili può sembrare qualcosa di scontato e del tutto naturale, ma per culture distanti, cristallizzate in remoti e ancestrali schemi di pensiero, non lo è affatto.
Molte popolazioni, come i Boscimani e i Pigmei dell’Africa, i Piraha͂ e altre tribù brasiliane e numerose comunità aborigene dell’Australia, non hanno la minima idea di cosa significhi contare: arrivate a malapena al tre o al quattro, definiscono le quantità successive con un generico “molti”. Così anche nella lingua latina solo i primi tre numeri (unus, duo, tres) erano declinabili, inoltre l’avverbio ter (“tre volte”) era considerato già sinonimo di “molto”, analogamente al très francese e all’inglese thrice.
La presenza di numeri in senso grammaticale vero e proprio come il duale (presente in greco, in sanscrito, in ebraico e in arabo) o i più rari triale e quattrale (presenti in alcune lingue dell’Oceania) così come l’uso di numerali differenti a seconda della tipologia di oggetto indicata sono chiaro sintomo di una comune incapacità dei nostri antenati di concepire il numero in senso astratto.
Relitti di tale antica concretezza del numero permangono nell’inglese pair, couple, yoke e brace che possono designare rispettivamente due scarpe, due persone, due buoi e due galline; un po’ come nell’italiano paio, coppia e pariglia.
Quando la necessità di fare di conto si impose culturalmente ecco che, a piccoli passi, si giunse a dominare quantità più grandi attraverso semplici conteggi per comparazione: per esempio, instaurando una corrispondenza tra il numero di animali del proprio gregge e un uguale numero di sassolini (calculi in latino), in modo da controllare eventuali furti o perdite.
Da qui l’allenamento al pensiero astratto ha fatto il resto, rendendoci consci del concetto di numero. Cosa hanno d’altronde in comune un gruppo di tre persone, di tre galline o di tre sassi se non il numero tre? Bertrand Russel, con la sua Introduzione alla filosofia matematica (1919) avrebbe elevato questo ragionamento ad un’esaustiva definizione di numero.
Ma imparare a contare non presuppone un uguale metodo di conta.
L’uso di basi diverse, nei secoli, ha prodotto una stratificazione di numeri e misure nelle nostre culture.
Nel francese quatre-vingts (4 x 20 = 80) s’avvertono tracce di un’antica base 20.
La versatile predilezione, tutta babilonese, per il 60 e i suoi multipli e sottomultipli è sopravvissuta nel nostro modo di misurare gli angoli e il tempo.
Dalla base 12 usata dai Romani per pesi e monete deriva la pervicacia delle unità di misura britanniche: un piede sono dodici pollici, dodici once sono una libbra, dodici pence fanno uno scellino. Furono d’altronde solo l’illuminista Rivoluzione francese e la successiva conquista napoleonica a uniformare su base 10 le unità di misura europee.
Insomma, ad un’occhiata più attenta il contare apparirà come un processo tutt’altro che spontaneo e naturale, ma piuttosto come un cammino tortuoso verso l’astrazione, nel cui odierno razionalismo decimale ancora si può inciampare in dozzine, sessantesimi di ora e paia di guanti.
Contare, dopotutto, è più che altro un fatto culturale.